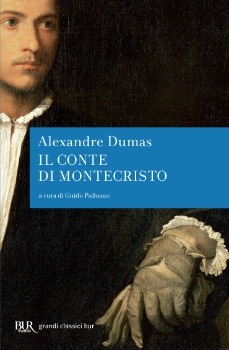 Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas, BUR
Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas, BUR
Quanto amo questo romanzo, ne consiglio la lettura incondizionatamente, un capolavoro assoluto.
Da capolavoro del romanzo popolare a capolavoro del romanzo: la storia della fortuna del Conte di Montecristo si potrebbe condensare nella lenta caduta di un aggettivo. Fin dal suo primo apparire, in quella Francia degli anni quaranta dell’Ottocento che era il più fervido e convulso laboratorio delle rivoluzioni europee, la storia dell’eroe borghese Edmond Dantès, eponimo della sfortuna e dell’ingiustizia, che si trasforma in spietato giustiziere, fu accolta dalle migliaia di avidi lettori di feuilleton come la più iperbolica incarnazione dello spirito del tempo. Un successo fulmineo, sancito dall’immediato passaggio all’edizione in volume e da un incredibile numero di ristampe e traduzioni. Ma fin da subito, quell’aggettivo, “popolare”, suonò, in tutta una parte della critica colta, come una netta discriminazione, se non come una condanna. Il lettore potrà seguire, nelle pagine della Prefazione di Claude Schopp, la ricostruzione della vicenda critica del romanzo. Schopp, che ha dedicato tutta una vita di studi a Dumas, disvela con precisione le ambizioni di una scrittura sapientemente costruita per portare all’estremo la tensione e la complicità del lettore. Situa, in una parola, il Montecristo nel posto che merita: all’apice della più felice stagione del romanzo europeo.
Indubbiamente, l’arresto del giovane marsigliese Dantès – ingiustamente accusato di complotto bonapartista – e i suoi quattordici anni di prigionia nel castello di If hanno un dominio speciale sull’immaginario del lettore, come l’isola di Robinson Crusoé rispetto alle successive vicende post-insulari (fascino invincibile delle reclusioni, della disperazione, del minimo dei mezzi). E nel castello di If, grazie alla sapienza millenaria dell’abate Faria, il Montecristo diviene per gradi una sorta di romanzo di iniziazione e di formazione di Dantès, sino alla sua eclatante evasione e alla conquista del tesoro dei Borgia che l’abate gli ha indicato trovarsi celato nell’isola di Montecristo.
Quando ritroviamo Dantès, ormai favolosamente ricco, prima a Roma e poi a Parigi è trascorso un decennio. Dumas ha steso un lungo silenzio su questi due lustri cruciali che il lettore conoscerà per barlumi (tra contrabbandieri corsi, briganti laziali e viaggi in Oriente). Di certo, in essi si è compiuta la trasformazione del leale ed entusiasta ufficiale di vascello nell’algido e misteriosissimo Conte che interpreta la vendetta come ineluttabile missione della Provvidenza. Ritroverà a Parigi difatti i suoi ex carnefici di Marsiglia, elevati socialmente e di censo in seguito a sfacciate carriere; per mesi, senza fretta, frequenterà con fredda cortesia cene, salotti e teatri di questi rappresentanti della Haute, scoprendo segreti inconfessabili del loro passato che via via utilizzerà come mezzi per la loro perdita. Il lettore, deliziato, non può che continuamente ammirare lucidità, imperturbabilità, diplomazia, preveggenza e mezzi sconfinati del vendicatore. La società si balocca paragonandolo, ammirata e incuriosita, a un eroe di Byron (citati all’occasione Manfred e Lara, lord Ruthwen e Werner) o a un principe orientale, ma non sospetta certo l’artefice di un contrappasso, il rimpatrio di un Ulisse della Restaurazione. Soltanto ai tornanti finali della feuilletonistica trama, quando si sono dischiusi tutti i fiori del male possibili (tradimenti, venefici, imposture, l’ombra di un infanticidio), allorché Dantès tiene perfettamente le fila dei suoi burattini è altresì riconosciuto dalla fidanzata di un tempo, la bella catalana Mercédés, ormai sposa al conte di Morcerf. Solo allora, in quel duetto appartato e toccante, le sicurezze del protagonista conoscono un trasalimento, la voce un’incrinatura. Se la vendetta andrà egualmente in fondo, certe assolutezze della missione si spuntano; e si diffonde, forse inevitabile, un sentore di pietas cristiana.
